Ciò che non sarebbe mai accaduto in una società in crescita, avviene oggi in quella morente, autolesionista e distruttrice di ogni ecosistema.
Articoli economici del 2007, appena precedenti la grande crisi del settore finanziario e la recessione delle economie finanziarie titolavano “fare grano con il grano” e “Come cavalcare l’impennata dei cereali al Chicago board of trade”. Erano gli albori di una industria finanziaria figlia di un progetto egemone e nichilista, che tenendo in scacco l’economia americana e di riflesso quella cinese e europea, aveva scoperto come poter accrescere i propri introiti attraverso l’industria agroalimentare e in particolare la produzione intensiva dei cereali. Oggi è ancora peggio, lo schema logico si fonda su una considerazione semplice: categorizzare il cereale tra le merci scambiabili in borsa vista la naturale dinamica della domanda/offerta. Ciò che dal campo si coltiva, assume in prima istanza un valore merceologico per l’industria alimentare a cui fa seguito un perverso sviluppo fatto di compravendite e depositi, nel quale infine si inseriscono mediatori finanziari che ne stabiliscono il valore e l’entità, generando scambi telematici mediante strumenti finanziari basati sul potenziale rendimento del cereale nel tempo. Questo processo trasforma il grano in commodity: nel vocabolario tra i termini economici si definisce commodity, “un bene per cui esiste domanda facilmente immagazzinabile e conservabile nel tempo”, ovvero “senza che perda nel tempo le caratteristiche originarie; l’elevata standardizzazione che caratterizza tali beni e ne consente una agevole negoziazione sui mercati internazionali come stock merceologico, ma pure come attività sottostante quale strumenti derivati e futures.”
Nella definizione si trovano elementi semantici che fanno pensare alle commodities quali beni di consumo come il petrolio, i minerali o i metalli preziosi: come mai allora anche il cibo rientra in questa categoria? Generi come zucchero, sale, cacao e caffè sono da sempre stati commerciati e scambiati nel corso della storia, tuttavia è da quando con il periodo coloniale si è adottato il sistema di produzione intensiva nelle nuove terre scoperte che l’incremento dell’offerta necessitava dello stimolo della domanda, cosa che nel corso di due secoli è pienamente riuscita e che ha prodotto l’inversione del rapporto in cui la domanda supera oggi largamente l’offerta, ma vediamo a che condizioni:
1) lo stile di vita occidentale si fonda sul consumo scriteriato di ogni bene, in particolare del cibo il cui tasso di spreco è pari a migliaia di tonnellate annue, 2) la dieta media occidentale è costituita in parte prevalente da carboidrati, proteine e sodio, 3) non esiste un tessuto di produzione artigiana, ma la trasformazione del cibo è in possesso dell’industria alimentare che gestisce moli enormi tra materia prima e prodotto finito, 4) il sistema produttivo industriale ha richiesto la necessaria implementazione del settore distributivo, che determina prezzi e standard produttivi ed è composto da pochi ma giganteschi operatori.
Si sono quindi semplicemente riprese le cattive vecchie abitudini coloniali di produzione e commercio, adeguandole ad un mondo globalizzato in cui è facile determinare mode e orientamenti di consumo sbilanciati, esponenziando con l’industrializzazione i volumi produttivi e tollerando una quota stabile di spreco e, non paghi, speculando sui prezzi che tali derrate determinano sia per volumi e richiesta, sia per i trend che ci si aspetta per il futuro. Sembra surreale ma esiste realmente chi incassa soldi per cedole finanziarie che si riferiscono ad un campo di grano coltivato chissà dove nel mondo quindi venduto e trasportato dall’altra parte stoccato in attesa di una nuova valutazione maggiore e rivenduto ad un grane mulino industriale che ne farà pasta, biscotti, panetti da distribuire con diversi brand negli scaffali della grande distribuzione. Senza approfondire la questione legata alla salubrità e ai requisiti igienico sanitari del prodotto scambiato, sovente ricco di tossine e funghi dannosi, i cui livelli nocivi sono falsati in fase di sdoganamento.
Sempre negli articoli di dieci anni fa si leggeva che il prezzo dei beni alimentari rincarava del 2,6% a fronte di un inflazione dell’1,5%, e gli analisti concludevano i propri interventi con valutazioni legate alla capacità dei grandi gruppi dell’industria alimentare di scaricare a valle, ossia ai consumatori, gli esborsi legati al trend dei prezzi delle materie prime sul mercato finanziario: difatti si diceva “i prezzi delle materie prime continuano a salire, se verranno pienamente trasferiti ai consumatori, porteranno i prodotti alimentari a prezzi mai visti”: in sostanza le perdite sui futures e sui costi industriali per l’approvvigionamento vengono scaricati sugli investitori e sui consumatori finali. Ma chi sono questi attori del comparto alimentare? Enormi conglomerati come Danone, Nestlè, AB Food, Kellog’s, la cui proprietà appartiene a quella casta industriale legata a doppio filo con la finanza speculativa con doppio passaporto, dove players come Morgan Stanley e Goldmann Sachs valutano le prestazioni e incentivano gli scambi, fagocitando con questo meccanismo perverso sia milioni di ettari di terre coltivabili, sia miliardi in valuta tra scambi finanziari di prodotti ad alto rischio, venduti a clienti ignari o speculatori avidi, nella migliore delle ipotesi inconsapevoli del danno inimmaginabile che arrecano all’intero ecosistema naturale, sociale ed economico, oltre alle profonde considerazioni etiche conseguenti.
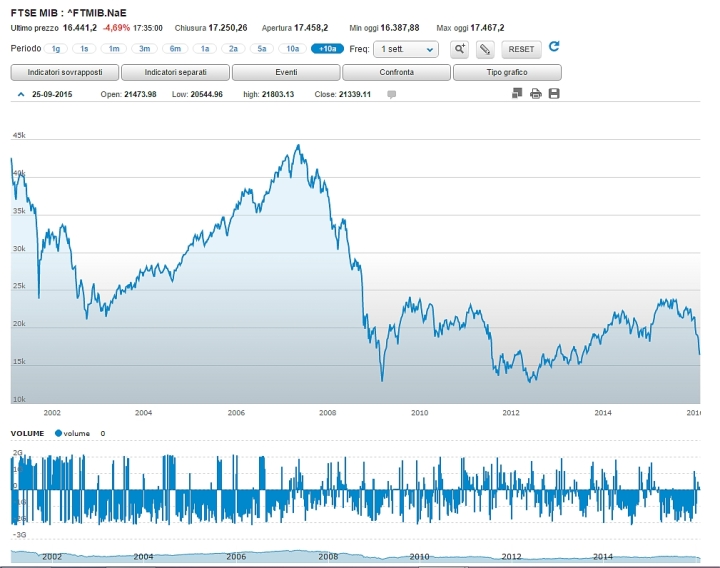
L’obbiettivo di fatto consiste nell’espropriare i popoli delle terre, dopo averli espropriati della sovranità alimentare (e monetaria, come ben sappiamo, ma è un piano adiacente) attraverso la pratica estensiva della produzione agroalimentare, che continuando nell’esempio dei cereali, si avvita con l’industria chimica e genetica: terreni dissodati trattati con fertilizzanti e seminati con sementi geneticamente modificate, crescono annaffiati con pesticidi e anticrittogamici ed enormi quantità di acqua, in un arco di tempo breve ma in grado di fornire una resa elevata e un quantitativo di macronutrienti pienamente conforme ai requisiti commerciali, per cui al posto di fibre, vitamine e antiossidanti, i grani vengono modificati al fine di avere solo amido e proteine, utili per i processi di trasformazione industrializzata, a loro volta studiati per garantire le migliori condizioni logistiche. A chi importa se fertilizzanti e altre sostanze distruggono la fertilità naturale del terreno? A chi importa se gli aerosol di antiparassitari hanno generato la scomparsa a livello mondiale delle api, unico ed insostituibile impollinatore che permette al ciclo vegetale di esistere? A nessuno tra i potenti, anzi, se si ascoltano i report dei loro uffici stampa, o le statistiche dei propri laboratori, come le analisi dei trader delle grandi banche, tutto sembra funzionare alla perfezione nel mondo idilliaco della postumanità, ma non è affatto così.
La soluzione alla devastazione, naturale e morale, delle terre e del tessuto sociale che lega i popoli (e non le élites), si trova nell’appropriarsi di una cultura del bene comune, nella consapevolezza che l’istruzione deve essere un mezzo per raggiungere il fine ultimo del benessere di prossimità all’interno della comunità umana. Occorrono nuove menti che sappiano cancellare con un colpo di spugna i parassiti che infestano l’economia, che stanno divorando dall’interno l’essere umano con la loro avidità e con l’usura che applicano a qualsiasi bene che possa produrre loro un ritorno. Occorrono politiche volte a regolare i consumi, non a stimolarli più del dovuto, occorre una consapevolezza che sappia rendere finalmente chiaro che il terreno fertile è una percentuale bassa delle terre emerse e quel poco è sottoposto naturalmente a fenomeni erosivi e quel poco lo si sta rendendo sterile, come i rapporti umani, fondati sul profilo economico o frivolo, evanescente come le generazioni di “millenials” o “snowflakes”, che fa tanto rima con cornflakes, per tornare al tema.
L’impronta ecologica, l’impatto che il sistema produttivo permette all’uomo di oggi di vivere, sta drammaticamente consumando ad un livello che occorrono decine di pianeti come il nostro per continuare a vivere con questi ritmi, le risorse non ci permettono di stimare un lungo futuro a questi ritmi. L’agricoltura andrebbe categoricamente esclusa dal sistema finanziario speculativo, l’industria calmierata con quote di produzione fissate sull’effettiva necessità e contestualmente dovrebbe essere impedito lo spreco.
Da un lato il modello descritto che si basa su una distorta valutazione del consumo e dell’industrializzazione agroalimentare, dall’altro esiste un approccio sistemico differente in cui l’agricoltura sa riappropriarsi delle buone pratiche agricole, utilizzare le sementi di antiche varietà, autoctone e minimamente impattanti, in grado di crescere autonomamente seppure con margini di rese inferiori rispetto a moderne varietà i cui genotipi sono stati modificati con esposizione nucleare. In cui i terreni sono valorizzati, nella parcellizzazione e mediante la rotazione delle colture. Le aziende agricole non corrispondono più in questa ottica a moderni latifondi facile preda dei conglomerati dell’industria agroalimentare, ma saranno appezzamenti diffusi tra molti piccoli proprietari, custodi della sovranità alimentare e orientati ad una economia di sussistenza. Occorre tornare ad una consapevolezza del gusto per le persone che da consumatori devono trasformarsi in gastronomi che non significa oziosi e melliflui gourmand, ma consapevoli beneficiari di un ciclo di produzione che segue l’intera filiera, conoscendone ogni passaggio contribuendo a mantenerla con scelte responsabili dalla stagionalità dei prodotti alla frequenza di consumo degli alimenti. Anche l’industria potrebbe rispondere a questa logica, se solo non fosse ricattata da prestiti a usura e se al legislatore irresponsabile non convenisse per questioni di corruzione o più cinicamente di PIL avere un alto impatto sul settore sanitario (visto il devastante effetto di un’alimentazione ipercalorica) o di alluvioni o altro che possa aumentare la spesa pubblica.

È inaccettabile e oltremodo scarsamente lungimirante supporre che il tema energetico possa passare attraverso l’etanolo, combustibile ricavato dal mais, perché per realizzare questo biocombustibile, si distruggono intere pianure fertili, esclusivamente in nome di profitti realizzati da plusvalenze che professionisti scambiano su mercati azionari. L’andamento dei prezzi sarebbe corretto identificarlo collegato al benessere che offre un determinato prodotto, in cui per benessere si intende una comunità che è sana e felice, che vive del proprio lavoro e di scambi onesti, fatti al mercato dai diretti coltivatori aiutati dallo Stato e dalla ricerca, e non nella dinamica in cui i profitti servono a generare provvigioni di centinaia di milioni a managers e finanzieri ma piuttosto a contribuire con l’innovazione responsabile e la cultura a costruire e tutelare l’intero ecosistema, in cui vive e progredisce il tessuto sociale che quanto è più virtuoso, tanto più resisterà al nichilismo chiamato globalizzazione.
l.p.
